
Ottessa Moshfegh: scrivere il male interiore
Ottessa Moshfegh nasce il 20 Maggio del 1981 a Boston, e sin da subito emerge come una personalità complessa e sfaccettata. I suoi romanzi e racconti spesso esplorano le sfumature della mente umana e spaziano dalla critica sociale alla psicologia, dalla filosofia alla cultura popolare. Come autrice, Moshfegh dimostra una sensibilità artistica distintiva e una capacità di cogliere dettagli significativi e spesso trascurati della vita quotidiana. Quello di Moshfegh è un realismo sporco che parla di vite ordinarie, lavori insignificanti, cattive condizioni familiari, economiche o di salute, e soprattutto di comportamenti autodistruttivi. Per questo motivo le sue opere sono spesso non convenzionali e provocatorie, mettendo a nudo tabù e temi controversi. Una scrittura come la sua merita un approfondimento sulla nostra rubrica Voci dalla Letteratura, perché, nonostante la sua giovane età, Ottessa Moshfegh ha già dimostrato di essere una delle voci più potenti della sua generazione.

La realtà scomoda e tortuosa di Ottessa Moshfegh
La penna dell’autrice statunitense è tagliente e mette il lettore davanti alla cruda realtà. Ogni suo romanzo è una nuova sfida non solo per il lettore ma anche per l’autrice. Moshfegh, raccontando dei suoi scritti, ricorda quando da adolescente visitò i suoi nonni e suo zio a Zagabria. Un giorno lo zio la portò in autobus fino a un cimitero in cima a una montagna e al ritorno le chiese di seguire un sentiero per tornare a casa. Da sola, Moshfegh percorreva arrabbiata la stradina ma poi iniziò a guardarsi intorno, e dichiara:
“E ho pensato, beh, quell’albero è davvero bellissimo. È davvero fantastico. E quando sono tornata a casa ero esausta e non ne ho nemmeno parlato a mio zio.”
Questo breve aneddoto viene messo in relazione da Moshfegh con la sfida creativa che è la creazione di ogni nuova storia, ma è anche un modo meraviglioso di vedere la sua produzione letteraria. Le sue storie mettono il lettore faccia a faccia con situazioni scomode e difficili da gestire, ma quando arriva l’ultima pagina ci si rende conto che l’intera lettura è stata quasi catartica. “È come prendere un autobus fino alla cima di una montagna e dover scendere a piedi”, dice Moshfegh. “Devi farlo. Come lo farai? Cosa scoprirai?”
McGlue: la claustrofobia della follia
Lo scorso mese Ottessa Moshfegh è tornata in libreria per Feltrinelli con un nuovo libro che in realtà è il suo romanzo d’esordio: McGlue. La storia pare sia ispirata da una vicenda pubblicata in un giornale della metà del 1800 e l’autrice ha dichiarato in merito al protagonista: “Una volta che ho iniziato a lavorare sul libro, ho potuto sentirlo divagare nel mio cervello, impaziente e selvaggio”.
È proprio così che McGlue emerge: volgare, arrabbiato, irragionevole, indomabile ma soprattutto totalmente ubriaco. Il rapporto di Moshfegh con i suoi personaggi è particolare e la stessa autrice dichiara: “Amo i miei personaggi, ma non mi piacciono. Non li amo come una famiglia. Li amo come gli spiriti che mi perseguitano. Sono semplicemente lì e devo accettarli.”
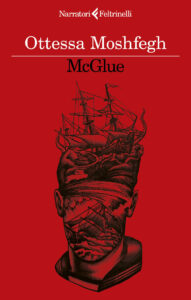
Proprio come McGlue perseguita Moshfegh, allo stesso modo il tema della persecuzione ritorna fortissimo nel romanzo, la cui storia è ambientata nel 1851. McGlue è un marinaio tenuto sottochiave nella stiva di una nave, ancora troppo ubriaco per essere sicuro di qualsiasi cosa, persino del proprio nome. È accusato di aver ucciso il suo migliore amico ma lui non ricorda di aver fatto alcunché. L’intera narrazione ruota attorno a McGlue, alla sua prigionia nella nave in attesa di sbarcare ed essere processato per il suo – apparente – crimine. L’autrice ci porta in una stanza buia, sporca e piccola. Solo McGlue e il fantasma del suo miglior amico. La penna di Moshfegh crea un’atmosfera claustrofobica che si stringe attorno al protagonista non solo in maniera fisica – con la piccola stanza-prigione – ma anche e soprattutto a livello mentale. Mentre la nave su cui si trova McGlue veleggia verso la sua fine, il marinario affonda sempre più nei suoi pensieri sconclusionati e ricordi confusi. McGlue è in fuga da se stesso e sono anni che si nasconde dietro una bottiglia di rum, di brandy, di birra, o di qualsiasi cosa abbia a disposizione. Finché alla fine la verità riesce a farsi strada nella sua mente annebbiata, e la consapevolezza dell’ultima pagina si ricollega alle righe dell’incipit. Moshfegh crea un loop perfetto, un ciclo fatto di violenza, amore e sofferenza che si chiude su se stesso lasciando al suo passaggio ben più di una vittima.
Il mio anno di riposo e oblio: la fatica di esistere nella narrativa di Moshfegh
La fuga da se stessi presente in McGlue diventa ancora più evidente in Il mio anno di riposo e oblio, che segue le vicende di una protagonista senza nome e del suo esperimento di “ibernazione” narcotica. Ambientato tra il giugno del 2000 e l’11 settembre del 2001, ci ritroviamo in una New York, all’alba del nuovo millennio. La protagonista, che si descrive come una specie di modella – giovane, magra, carina – è da poco laureata alla Columbia e vive, grazie a un’eredità, in un appartamento nell’Upper East Side di Manhattan. Nella vita della protagonista senza nome c’è qualcosa che manca, c’è un vuoto che non riesce a riempire e di cui non sa come sbarazzarsi, così si convince che la soluzione migliore sia dormire un anno di fila e non provare alcun sentimento. forse addirittura guarire. Il suo obiettivo è quello di essere “rinnovata, rinata“, come “una persona completamente nuova”. Le pillole che consuma “Trasformavano tutto, persino l’odio, persino l’amore, in lanugine che potevo soffiare via. Ed era esattamente quello che volevo – le mie emozioni che passavano come fari che brillano rapidi attraverso una finestra, mi superavano illuminando qualcosa di vagamente familiare, poi svanivano e mi lasciavano di nuovo nel buio.”

La fuga dal mondo e da se stessi riflette l’odierna sensazione di non sentirsi mai al posto giusto da nessuna parte. Moshfegh anticipa quella tendenza letteraria che nell’ultimo anno si è sviluppata sempre di più: quella delle sad hot girls. Ragazze bellissime ma con un vuoto interiore da cui rischiano di essere ingoiate, che camminano senza meta in un mondo che sembra non avere posto per loro. La sad hot girl di Moshfegh cerca di fuggire a tutto usando dei sonniferi per ridursi in uno stato di incoscienza quasi perenne, nascondendosi: dal mondo, dalle sue responsabilità, dalle sofferenze e soprattutto da se stessa.
I genitori della protagonista sono morti entrambi a sei mesi di distanza l’uno dall’altro, durante il suo primo anno di liceo, e Moshfegh riprende e al tempo stesso rifiuta quello che Parul Sehgal ha recentemente descritto come “la trama del trauma”. Questo archetipo tende a portare la curiosità del lettore non sul futuro del protagonista, come potrebbe invece fare un matrimonio, ma sul passato: il lettore pensa “ma cosa le è successo per arrivare a fare ciò?”. La verità però è che la protagonista di Moshfegh rigetta questo trauma attraverso la più totale indifferenza, lasciando forse il lettore insoddisfatto sul passato della protagonista, ma tenendolo comunque incollato alle pagine durante il suo folle esperimento del sonno che, ad un certo punto, diventa un progetto artistico. Lasciando andare qualsiasi cosa, la protagonista diventa una tela bianca, pronta a rimettere piede nel mondo.
Lapvona: la fiaba nera di Moshfegh
Lapvona, l’ultimo – al momento – romanzo scritto da Moshfegh nasce durante la pandemia di Covid-19. La clausura forzata e le conseguenze sul mondo e sulle persone hanno portato Moshfegh a trasferire quelle sensazioni negative su carta. Ciò, unito alla convinzione dell’autrice secondo cui le fiabe manchino di realtà, ha portato alla nascita di Lapvona. Il racconto si svolge nel corso di un anno nel villaggio medievale di Lapvona, che dà il titolo al libro. Il protagonista è Marek, il figlio maltrattato di un pecoraio, nato con alcune malformazioni corporee che ne hanno segnato l’esistenza. Malvisto dall’intero villaggio per il suo aspetto e per il suo comportamento selvaggio, Marek, in un capovolgimento totale degli eventi, si ritrova a diventare il pupillo e il giullare del governatore Villiam. Quest’ultimo ha un appetito che non conosce fine, pare che niente riesca a saziarlo, e il riflesso di quello che avviene nel suo corpo si ritrova nella sua mente: Villiam ha un gusto altrettanto sviluppato per la crudeltà. Il cibo si fa portatore di orrore e violenza; da una parte la carestia del villaggio mentre dall’altra l’abbondanza spietata del palazzo. Moshfegh crea una fiaba oscura, in cui nessuno vive mai felice e contento, trascina il lettore in un mondo sporco e gretto, dove sopravvive solo il più potente mentre tutti gli altri sono lasciati a marcire in silenzio.

Villiam, come un fittizio Maria Antonietta, avrebbe potuto benissimo dire: “Se non hanno più pane, che mangino brioche”, tornando a godere di qualche punizione inflitta a chi per sopravvivere deve sottostare alle sue angherie. Moshfegh dipinge una fiaba medievale verosimile, sollevando il velo di pacifica finzione che negli anni si è posato su alcune storie. L’autrice va oltre la spietata verità scritta dai fratelli Grimm, ne esagera ed esacerba i contorni, creando una storia in cui non c’è – e mai ci potrà essere – redenzione per nessuno dei personaggi. Lapvona è un racconto biblicamente violento, in cui non c’è spazio per la speranza o per il lieto fine. È un susseguirsi di immagini crudeli, disturbanti e traumatizzanti, in cui l’unico scintillio è negli occhi di Villiam e Marek mentre si beano della loro crudeltà.